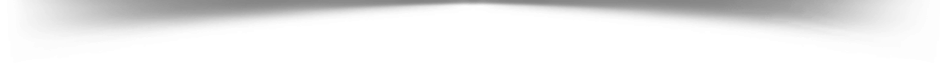La fine
- DATE 12 Gen , 2021
- Author: sara
- COMMENTS Leave a comment
“Quindi è così che finisce tutto?”
Questo si domandava Elsa, di fronte alle ante spalancate del grande armadio doppia stagione di sua madre.
Una sfilza di gonne, camicie, pantaloni che si susseguivano in maniera precisa, suddivisi per colore.
Tutti capi piuttosto ordinari, tinte pastello, modelli semplici, senza alcuna personalità: nessuna traccia di guizzi eccentrici né di colori accesi.
Del resto sua madre non si era spenta solo tre giorni prima, in quel grande letto dalla testiera antica di legno intagliato.
La sua era stata un’intera esistenza vissuta all’insegna dell’anonimato: spenta, grigia, in sordina.
E quell’ammasso di abiti di cui ora Elsa doveva disfarsi, era la rappresentazione precisa della sua vita.
Spostò una gruccia, e tirò fuori un vecchio cappotto cammello che ricordava di averle visto indosso solo per alcune grandi occasioni: la laurea di Carlotta, e poi la cresima di Francesco.
Si ricordava quanto avesse insistito perché si comprasse qualcosa di nuovo.
Ma sua madre no, non aveva voluto sentire ragioni.
Si chiedeva cosa avrebbe fatto di tutti quei vestiti, se avesse senso portarli a qualche associazione che raccoglieva abiti per i bisognosi.
Si chiedeva se era giusto farlo subito, via il dente via il dolore, in una sorta di rito di liberazione.
Pensava che il funerale sarebbe stata la parte più difficile.
Anche se certo, non poteva essere più difficile degli ultimi mesi, passati in un inferno di visite, dosaggi di medicine, pranzi e cene, badanti che si alternavano giorno e notte, pannoloni zuppi di urina, bombole di ossigeno, appuntamenti alla Asl, analisi, infermieri per casa, morfina…
Ma adesso si ritrovava di fronte al gran finale: dover gestire tutto ciò che resta, i mobili, la casa, quei vestiti.
I ricordi.
Ogni capo le richiamava qualche momento alla memoria.
C’era la camicetta che usava per andare a messa, in pendant con una gonna color vinaccia.
C’era l’impermeabile blu dei giorni di pioggia.
C’era il pullover celeste di cachemire che indossava ogni Natale.
E c’era soprattutto un odore lieve, di borotalco misto a naftalina che aleggiava, portandosi appresso un’immagine di sua madre sempre più sfuggente.
Col passare dei giorni anche quel profumo si sarebbe dissolto; come l’immagine del suo viso o la sua voce, che già non ricordava più.
Era questo, dunque, il gran finale?
Giù il sipario, lo spettacolo è finito, signore e signori.
Come quando assistevano al saggio di danza di Carlotta bambina, e lei sbirciava di soppiatto il profilo di sua madre, gli occhi che le si inumidivano e brillavano al buio, di fronte alle luci di scena.
E giù a battere le mani finite le esibizioni che a lei apparivano tutte ugualmente monotone, in un ripetersi di gesti, braccia alzate, gambe che volteggiavano, salti, piroette, che invece entusiasmavano le altre madri, soprattutto la sua.
E invece niente applausi questa volta.
Restava solo il vuoto di un’altra esistenza strappata alla vita lasciando dietro di sé una scia infinita di perché, come la bava di una lumaca che brillava per seccarsi e poi sparire, senza lasciare traccia.
Nessuno te lo dice che la fine è così, un nuovo inizio travestito da ineluttabile finale.
Come quando guardando fuori dalla finestra, Elsa osservava le foglie del grande olmo del giardino condominiale diventare gialle e poi arancioni, e infine lasciarsi andare in volo, segnando, per lei, più la fine dell’estate – la sua stagione preferita – che l’inizio di un autunno tiepido e doloroso nella sua bellezza.
O come quando ogni Capodanno sentiva i fuochi d’artificio in lontananza, mentre le luci aggrovigliate nel presepe si accendevano e spegnevano ad intermittenza, già esauste, in attesa della fine di quel periodo estenuante di incontri forzati, aperitivi, pranzi e cene che si alternavano come le ghirlande sull’albero di Natale in una spirale senza fondo.
O come quando sua madre la sera si metteva a lavare i piatti, la sigla della Cartolina di Enzo Biagi come colonna sonora, mentre suo padre inanellava parole nel Bertazzaghi del venerdì, e lei e sua sorella giocavano con le Barbie ai suoi piedi, in attesa che anche quella giornata finisse.
O come la domenica, quando la fine della settimana era segnata dalle mattine in cui lei e sua sorella si svegliavano con l’odore di soffritto misto a quello della focaccia di patate appena infornata, come una carezza familiare.
Il pranzo della domenica, quando al grande tavolo rotondo in sala sedevano anche i nonni che arrivavano puntuali a mezzogiorno, carichi di vassoi di paste e banconote verdi da cinquemila lire, una ciascuna, a lei e a sua sorella.
Ed era ogni volta l’inizio di un incontro – che somigliava più al quadrato di un ring con i suoi boxeur che ad un pranzo in famiglia – carico di tensioni, convenevoli e sottintesi, in cui sua madre si districava solo grazie alla sua abilità ai fornelli, che le permetteva di sparire in cucina per la maggior parte del tempo.
La suocera che ogni volta faceva il gesto affettato di aiutarla a sparecchiare, e sua madre che di rimando la faceva restare a sedere con una mano appoggiata dolcemente su una spalla, in un gioco delle parti che si concludeva puntualmente con la stessa battuta: “Lascia almeno che prenda le paste in frigo!”.
E sua madre che sorrideva condiscendente, chiedendo a noi di aiutare la nonna, in cambio del privilegio di scegliere per prime il pasticcino da mangiare.
Pensava a tutto questo, Elsa, di fronte al grande armadio. Le ante spalancate come fauci pronta a divorare lei e i suoi stupidi ricordi.
Chiuse gli occhi, immaginando di essere invece nella grande casa di campagna dove passava le estati della sua infanzia, solo tra donne: lei, sua sorella, sua madre, sua nonna e diverse zie, alcune di sangue – come la sorella di sua madre – altre acquisite, come le comari del vicinato che passavano interi pomeriggi sull’aia a sbucciare pomodori cotti dal sole per preparare la salsa, spettegolando degli ultimi avvenimenti giù in paese.
La Lorella che aveva picchiato per l’ennesima volta il marito rientrato a casa ubriaco, giurando di nuovo che sarebbe stata l’ultima.
“Fino alla prossima, certo”, sghignazzava la Bice asciugandosi il sudore con il dorso della mano rossa di polpa di pomodoro.
Don Guido, che confessava sempre la stessa parrocchiana, e chissà quell’anima pia cosa aveva da raccontare e quanto piaceva a Don Guido quello che raccontava.
L’Andrea e la Letizia che ogni anno dovevano sposarsi e ogni mese si lasciavano per riprendersi quello successivo.
E lei e sua sorella che giocavano coi gattini dell’ultima cucciolata, prima di vederli sparire sotto le grinfie di qualche contadino che li annegava senza troppi convenevoli, ascoltando il chiacchiericcio delle donne e fantasticando su cosa raccontasse la devota parrocchiana a Don Guido durante le sue confessioni.
Elsa ricordava sua madre lavorare in silenzio, un sorriso storto a strapparle le guance quando la Bice se ne usciva con qualche battuta sconcia, e poi vederla alzare nell’ora di mezzogiorno per mettere in tavola sotto il grande pergolato di fronte casa.
Il venerdì sera segnava la fine della quiete femminile, quando gli uomini raggiungevano le mogli, lasciando la città morsa dall’afa per cercare refrigerio nelle colline del Monferrato.
Arrivavano con la “millecento” bianca di suo padre, strombazzando, e portando borse di vestiti da lavare e dolciumi per noi bambine.
Suo padre scendeva dall’auto con l’aria stanca, la camicia incollata alla schiena per il sudore, le maniche arrotolate, la sigaretta spenta fra le labbra, scaricava i borsoni dalla macchina e salutava mia madre con un bacio fugace mentre oltrepassava la soglia di casa.
E il sabato e la domenica segnavano non solo la fine della settimana, ma soprattutto la fine della quiete che quelle donne si ritagliavano in sordina, fatta di confidenze, lavori suddivisi equamente, pasti meno elaborati e la pennicchella pomeridiana sotto il fico dietro casa, mentre la voce di Lucia che leggeva poesie d’amore cullava il riposo delle altre donne.
Elsa si riscosse per un rumore improvviso: una persiana sbatteva mossa dal vento.
Si avvicinò alla finestra per chiuderla, e guardò fuori, osservando il viale alberato striato di rosso e arancione.
Le prime foglie cadute a terra avevano creato un tappeto che fin da bambina amava calpestare per sentirle scricchiolare sotto ai piedi.
Anche quell’anno l’estate era finita.
(Foto dal web)
Tag
- fiducia
- musica
- vita da single
- vita
- 8 marzo
- Guerra
- Inverno
- winter
- Torino
- immigrazione
- Salone del libro
- burian
- frozen
- freddo
- Collaborazioni
- figli
- Pilates
- Bullismo
- Sport
- Benessere
- Ghost
- Film
- Alluvione
- Halloween
- Anni '90
- Moda
- Parigi
- Nonna
- Mostre
- discr
- violenza
- 25 Novembre
- andrà
- valigie
- gabbia
- camminare
- il corpo del
- G8
- incipit
- partenze
- tiger
- ridere
- decathlon
- dormire
- inizi
- fine
- mestruazioni
- love
- 11 settembre
- relaz
- rivoluzione
- politica
- social
- Gli invisibili
- aborto
- festa del papà
- black lives matter
- gabbiere
- felicità
- happinessa
- andràtuttobene
- Immuni
- Buenos Aires
- Migranti
- Letture
- maschere
- Serie TV
- Settembre
- Blog
- Ricordi
- amicizia
- Storie di Donne
- pregiudizi
- Pubblicità
- san Valentino
- Amsterdam
- Diritti
- paura
- ragazzi
- inaugurazione
- mare
- il corpo delle donne
- Ponte San Giorgio
- femminismo
- Ballate
- New York
- Anno Nuovo
- Libri
- Figli senza diritti
- Bellezza
- scrittura
- travelling
- lockdwon
- pride
- Morte
- Natale
- Famiglie arcobaleno
- DAD
- Gender
- Attualità
- Tempo
- Arte
- Racconti
- Ponte Morandi
- omofobia
- razzismo
- Vacanze
- monamour
- scuola
- covid
- Famiglia
- Genova
- Estate
- omosessualità
- lockdown
- Viaggi
- A come amiche
- Bambini
- Donne
- coronavirus
- quarantena
- D come donna
- Discriminazione
- Amore
- Maternità
- Lifestyle
- Relazioni
Articoli recenti
Categorie
×